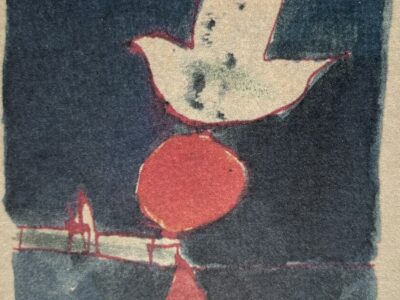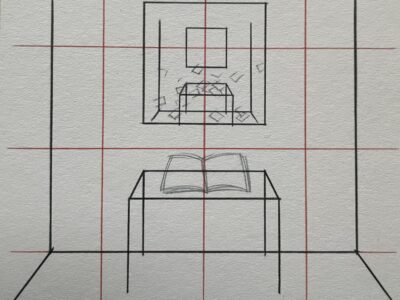Ho scritto un racconto un po’ più lungo del solito, almeno rispetto a quelli di Vecchi scemi (Pequod 2017) e ho plagiato mia nipote, l’altra non era ancora nata quindi ne ho plagiata soltanto una: nel senso che mi sono annotato le sue uscite più imprevedibili, in qualche modo distopiche, perché la realtà era la stessa eppure sembravano due mondi diversi e due modi diversi di descriverla. Così nel giro di qualche anno è venuto fuori questo romanzo, La tartaruga di stoffa (Pequod 2021) che però parla anche d’altro. Sia chiaro che sono problemi di Ugo, il personaggio principale, e in parte anche di Camilla, la nipote. Io sono più buono e più estremista.
La tartaruga di stoffa è un racconto che vive di dialoghi. Nei dialoghi si galleggia, si porta avanti la vita di ogni giorno, si ride, anche. Certo, si ride, perché la comicità quotidiana, specchio e contraltare della disperazione, è nel parlato di cui è intessuto questo libro: nelle conversazioni giocosamente assurde o impietose, in quelle disilluse con gli amici (il pittore Occhialini, l’anarchico Pierre) o in quelle mute con le istituzioni che usano le anti-lingue, o in quelle con il “gruppo di lettura”, infine nelle riflessioni, tipo questa: “Ma io sono un robot, meditava Ugo. Un vecchio robot arrugginito. Mi muovo come un essere umano, e parlo ai miei circuiti interni, oppure sono loro che parlano a me. Ci parliamo, se i pronomi personali significano qualcosa. Questa specie di assemblaggio mi pare un po’ antiquato, comunque sarebbe una meraviglia il corpo, se non andasse in malora. C’era quel modo di camminare da infartato. E lo sguardo perso nel vuoto. Non troppo perso. Ma in prospettiva sempre più perso nel vuoto. E non sapeva perché. E forse non c’era un perché.”
Non credo che ci siano rappresentazioni di una condizione nuova e diffusa, nonni maschi che allevano nipoti femmine, molto piccole, non delle Zazie. Quindi è anche preoccupato Ugo. Sente che deve addestrare la bambina a voler ribaltare quel codice di convenzioni ormai senza fondamenta che sopravvive nelle relazioni sociali e nei linguaggi: perché non si dice “donna sapiens”? “Hai ragione te, Camilla. Non è lo stesso, aveva detto Ugo. Dovrei imparare a parlare, tutti dovrebbero imparare a parlare. Il vocabolario è sbagliato. E io sono vecchio ma non è una giustificazione, anche i vecchi devono imparare a parlare”.
Però alla fine, come dice l’autore, quando si scopre appunto chi è l’autore: “E poi sotto traccia ho questa strana sensazione (ma anche il dubbio), che ci sia dell’altro …”.
Qualcuno mi ha detto che è piuttosto polemico e perfino feroce, questo libro, ma dai … Se anche fosse, ripeto, sarebbero problemi di Ugo. Comunque, per chi volesse capirci qualcosa (ma non posso assicurarlo) c’è questo invito:

E grazie di cuore alla Scuola di scrittura Passaggi e a Carolina Iacucci che ha accettato di parlarne.
*
Una lettera di Stefano Paci
Caro Marco,
Ieri ho finito di leggere il racconto-saggio sull’onesto, curioso, indomito nonno Ugo.
La lettura è stimolata dalla lucidità in cui avvolgi i tuoi cari personaggi nelle tue (di Ugo) riflessioni, causate non dalla vecchiaia ma dalla presa in carico di una realtà complicata e in pericolo di estinzione.
Vivacissime considerazioni che aiutano anche la mia voglia di stare con i piedi per terra e imparare a relazionarmi sempre meglio con quelli che non mi piacciono e con i luoghi dove il mio radar segnala pericolo.
È quasi trilleresco il modo che affascina la lettura. Mi è sembrato di essere in qualche luogo di un racconto di Italo Calvino e con la leggerezza “fisica” di Carlo Rovelli.
Mi piacerebbe che Ugo, con l’aplomb di un inglese alle cinque del pomeriggio, apra la finestra e con grande voce mandi tutti “affanculo”.
In fanese però.