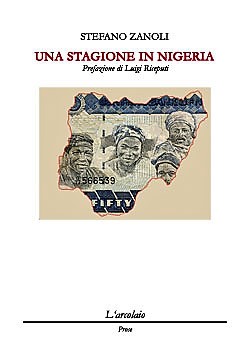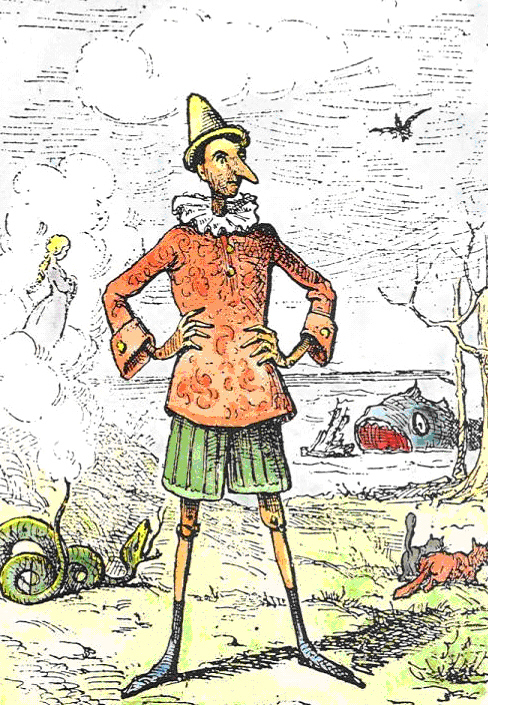«La servitù volontaria prende il posto della proibizione imposta» (Mario Tronti). E’ la tragica consapevolezza a cui arriva uno dei maggiori filosofi italiani ricordato come promotore negli anni ‘60 del secolo scorso del tanto discusso operaismo (Operai e capitale, 1966) e come spericolato incursore teorico, armato di una volontà di ricerca mai quieta, mai pacificata, che lo porterà attraverso la cosiddetta autonomia del politico e il corpo a corpo con il pensiero conservatore novecentesco – Carl Schmitt in particolare – a un’ultima fase della sua vita in cui dopo aver ricoperto anche ruoli istituzionali – è stato Senatore della Repubblica – si sarebbe come fermato a riflettere sulla storia del secolo “grande e terribile” (il ‘900), fortemente intrecciata con la sua, in una condizione da lui stesso definita di monachesimo
combattente lasciando il chiacchiericcio filosofico «ai tanti che fanno filosofia in piazza».
Il risultato di questa riflessione, inteso anche come lascito teorico della sua opera che attraversa sessant’anni di storia di questo Paese, è stato il testo postumo Il proprio tempo appreso col pensiero (Tronti è scomparso il 7 agosto 2023) che ho appena finito di leggere insieme ad un altro volume all’apparenza appartenente a un altro mondo, un mondo completamente diverso, quello del Kenya, ex colonia britannica indipendente dal 1963: Decolonizzare la mente del grande intellettuale, scrittore e letterato africano Ngugi wa Thiong’o, scomparso anche lui poco tempo fa.
Ho l’abitudine, a volte fine a sé stessa, di incrociare la lettura di due testi contemporaneamente per misurarne le possibili interlocuzioni e stavolta non sono rimasto deluso! In effetti attraverso il racconto e la riflessione serrata di due “irriducibili” è emersa nitidamente ai miei occhi la cifra della nostra epoca, di questo allucinogeno ventunesimo secolo: è finalmente giunta per i padroni del mondo l’era della servitù volontaria, l’epoca in cui la recinzione al pensiero e alle azioni dei subalterni, dei “perdenti”, non è data tanto dall’imposizione anche violenta della volontà dei più forti, dei vincitori della globalizzazione, quanto dalla convinta sottomissione dei più deboli – la stragrande maggioranza – alla volontà di dominio e di supremazia degli stessi padroni del mondo e ai loro desideri più inconfessabili.
Emerge il gusto impagabile della sottomissione al capitale, ai vecchi imperi coloniali mai morti, ai nuovi imperi sempre più voraci da parte di coloro che avrebbero dovuto essere argine contro questa delirante e suicida organizzazione del mondo, una resa unilaterale di quei gruppi dirigenti che avrebbero dovuto rappresentare una forma di resistenza a vecchi e nuovi domini e che spesso invece si sono trasfigurati in fattivi e zelanti collaboratori degli stessi dominatori.
E’ la parabola comune alle forze della vecchia sinistra europea e alle nuove classi dirigenti africane, spesso garanti della continuazione del saccheggio delle risorse umane e naturali che l’Africa possiede in abbondanza. Da qui la comune consapevolezza, di Tronti e di Thiong’o, che senza una propria cultura, un proprio pensiero sulla storia, non è possibile alcuna autonomia e nessuna affermazione della dignità umana dei subalterni: l’autore keniota da un certo momento in poi non scriverà più in inglese, la lingua dei colonizzatori, e comincerà a scrivere in gikuyu, la lingua del suo villaggio in cui avvierà anche un esperimento teatrale nello stesso idioma, individuando proprio nel teatro la forma più diretta di comunicazione con la popolazione contadina e dove incontrerà un consenso travolgente per lui causa di molti guai giudiziari. E, anche se può risultare sorprendente – per qualche “anima candida” pure imbarazzante – i processi molto affini in atto negli ultimi quarant’anni in Africa e in Europa finiscono per condurre i due volumi a un
epilogo molto simile: infatti se i gruppi dirigenti post coloniali africani «la vedono allo stesso modo dei vecchi colonizzatori e implorano di fatto una ricolonizzazione dei loro paesi per diventarne i governatori neo-coloniali, residenti in moderne fortezze e felici come neo-schiavisti dei loro stessi popoli» (Thiong’o, p.95), i gruppi dirigenti delle sinistre italiane ed europee, in preda «a una deriva antropologica e culturale hanno finito per abbracciare un lento graduale totalizzante processo di imborghesimento: impressionante osservare come, in molti, di quel passato, in cui hanno addirittura esercitato funzioni dirigenti nelle organizzazioni del movimento operaio, non sia rimasto niente , ma proprio niente, in un voluto e coltivato vuoto di memoria, in una disponibilità all’ascolto delle sirene del tutto è cambiato, senza ripugnanza per lo stato delle cose esistente, ogni passione spenta, ben accomodati nelle generose offerte dei dispositivi ben oliati di ricchezza e potere: tranquillamente passati dalla pretesa di egemonia a una pratica di subalternità» (Tronti, p.27).
Alla fine del XVI secolo de La Boétie mai avrebbe immaginato la fortuna della categoria di “servitù volontaria” per capire lo stato delle cose e del mondo di cinque secoli dopo!
Marco Savelli
Ngugi wa Thiong’o, Decolonizzare la mente, Jaca Book, 2021
Mario Tronti, Il proprio tempo appreso col pensiero, Il Saggiatore 2024